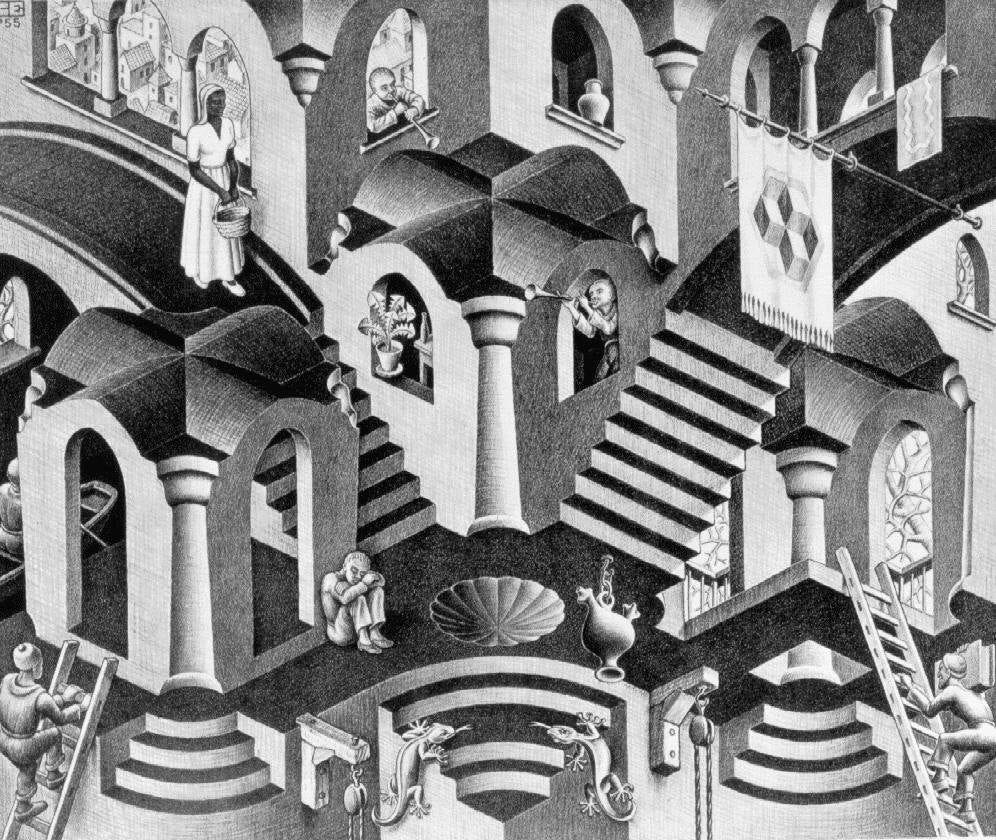[Pensieri a caldo, scritti in una giornata così uggiosa da essere rassicurante, nei sotterranei dell’Università di Milano, biblioteca di Storia, subito dopo aver finito Cent’anni di solitudine, con un’amica al fianco.]
Se esistesse un romanzo con la mestizia secolarizzata di Tolkien, la precisione elencativa di Borges, la forza mitica di Goethe e la ricchezza enunciativa di Balzac, l’attenzione agli scarti di Flaubert e l’ambizione massimale di Proust, il gusto per la ripetizione di Joyce e il profetismo di Eliot, quel romanzo avrebbe titolo Cent’anni di solitudine.
Una indefinibile terra di mezzo tra la sconsideratezza dell’eccesso e la seduzione della reticenza è il territorio entro cui si muove la prosa di Marquez, allo stesso tempo fluvialmente descrittiva eppure dotata del carattere incompleto dello schizzo. Ogni personaggio è un archetipo di una personalità, i cui tratti sono abbozzati tutti al punto da essere la forma generale di un tipo umano, sfuggendo sia alla verbosità del didascalismo sia alla precisa vaghezza dello stereotipo.
Le azioni insignificanti hanno il carattere mitico della magia, così come gli eventi inspiegabili hanno il carattere quotidiano degli eventi irrilevanti. Questo doppio cortocircuito crea un’atmosfera di equivalenza degli eventi che suggerisce, attraverso lo stile che si fa contenuto, il messaggio dell’opera: la terribile insignificanza delle vicende umane.
Questa oscillazione infinita tra l’enormità irriducibile di una vita umana e l’ironia distaccata nel riconoscerne il valore “dall’alto”, è lo spazio semantico dove si muove Marquez. Ma in questa oscillazione un punto diventa funzione dell’altro in modo intercambiabile: è vedendo la vita con distacco che possiamo renderci conto del dramma della sua insignificanza, che si scontra con l’illusione di importanza di chi la vive in prima persona; e, allo stesso tempo, solo guardando da vicino la vita, quasi ignari della possibilità di una prospettiva dall’alto, è possibile avere il materiale necessario a un’astrazione di spessore, che valga la pena di essere percorsa. Se non c’è nulla di valore da cui distaccarsi, a cosa varrà il distacco e cosa ci farà scoprire? La terza persona presuppone sempre la prima. Dall’alto della terza persona, guadagnata attraverso il sudore della sierra e rischiando la follia alla ricerca delle invenzioni millenarie come Jose Arcadio Buendia, Marquez ci fa vedere lo stagno paludoso dei destini di tutti i suoi personaggi. Eroici, incredibili, eccentrici, meravigliosi e anche meschini, irrilevanti e dimenticabili.
L’enfasi delle gesta eroiche è subito succeduto dalla glissa paesana degli eventi esagerati. Dopo qualche generazione, nemmeno a Macondo si crederà più alle mitiche 32 guerre iniziate dal colonnello Aureliano Buendia. Anche quello che credevamo il fondamento della mitologia personale del popolo di Macondo, svanisce prima nel libro di quanto svanisce nella memoria del lettore. Una beffa. Tutto si rivela superabile, rompendo il patto tra lettore e autore che conferisce l’alone mitologico anche agli eventi narrati senza enfasi, per il fatto stesso che sono stati selezionati come eventi da narrare.
Marquez li fa tracimare tutti nel pantano dei ricordi offuscati di generazioni che si succedono in eterno senza imparare nulla, in una storia che suona come cent’anni in sineddoche della Storia di Tutto. Nessuna cartina geografica, nessun albero genealogico a soccorrere il lettore nello sforzo di discernimento tra le ripetizioni di nomi imposti dalla rigidità antropologica dei popoli del sud: tutti i personaggi maschili si chiamano o Aureliano Buendia, o Jose Arcadio Buendia, in un groviglio di ripetizioni che diventa letterariamente memorabile e geniale non appena si comprende che quella confusione non deve essere vinta ma è esattamente il senso che il testo deve suggerire. L’intercambabilità di tutti, il destino uguale di tutti. Sono tutti uno e uno è tutti di nuovo, condannato a ripercorre il destino fatto di nulla di ogni altro. Come i due gemelli Aureliano Segundo e Jose Arcadio Segundo. Nessuno saprà mai chi è chi perché fin da piccoli si erano scambiati i nomi e avevano continuato a farlo fino a dimenticare loro stessi chi era chi. Il circolo della ripetizione è prima di tutto onomastico.
Le meccaniche letterarie che somministrano al lettore il senso di circolarità inaggirabile del tempo della solitudine dei Buendia sono varie (dall’assenza di alberi genealogici, alla ripetizione onomastica, alla solitudine che accomuna tutti) ma tutte contenute nell’incipit del romanzo. Non è un caso. Anzi, questa stessa capacità di condensare in ogni frase del romanzo il suo senso profondo, di usare ogni frase per ricapitolare tutto il resto, è una meccanica di cui Marquez si serve per creare il suo effetto retorico. Ogni frase presa a caso nel romanzo funziona come una mise en abyme del suo senso generale e ripete nella sua struttura la frase che crea dalla giustapposizione con ogni altra.
L’incipit dicevo: tutto si gioca a livello di due figure retoriche: prolessi e analessi. Davanti al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendia, ricorda il momento mitico e fondativo in cui suo padre, Jose Arcadio Buendia, lo porta a vedere il ghiaccio. Ma non è un semplice flashback quello con cui inizia il romanzo. A ben guardare è un flashback innestato in un flashforward. L’incipit testualmente recita: “molti anni dopo, il colonnello Aureliano Buendia avrebbe ricordato…”. Subito dopo queste righe, Marquez inizia la vera narrazione parlando del padre del colonnello Aureliano. Quindi, il libro non si apre con un semplice falshback: quando l’incipit davanti al ghiaccio finisce, non torniamo al colonnello davanti al plotone di esecuzione. Il romanzo si apre con una anticipazione al cui interno troviamo un flashback. Cent’anni di generazioni ed episodi quotidiani condensati in un unico punto dello spazio e del tempo, continuamente, gli uni che si ricapitolano negli altri, tutti ricapitolati a loro volta dentro il simbolo che li contiene tutti: Macondo, fondata dal nulla e strappata da un vento apocalittico alla memoria degli uomini, per sempre, alla fine del romanzo mentre l’ultimo degli Aureliani legge il suo stesso destino e quello della sua stirpe nella tempesta di polvere e ricordi che si abbatte come una marea inarrestabile sul villaggio decaduto, immagine di tutte le città e di tutti gli imperi. Insieme all’incipit, è questo finale a chiarire il senso della storia narrata da Marquez.
Alla fine del romanzo scopriamo che il destino della famiglia Buendia e la condanna della loro solitudine era già stato scritto e predetto da Melquiades, lo zingaro morto di febbre nelle secche di Singapore, nelle cui pergamene le sorti della famiglia Buendia erano già state tutte comprese e messe da parte con l’algida alterità di un dio.
Ma uno scarto si apre tra quelle pergamene dove viene ricapitolata la storia dei cento anni di solitudine della famiglia Buendia e Cent’anni di solitudine, il romanzo che teniamo stretto tra le mani. Il libro che leggiamo non è il resoconto scritto delle pergamene di Melquiades, perché quelle sono destinate a venire divorate dal vento, sbrindellate dallo stesso caso indisciplinato che ha portato alla fondazione di Macondo nella sierra, cento anni prima. Marquez gioca sporco per raggiungere i suoi fini: instilla nel lettore, lo scetticismo meta narrativo riguardo alla natura finzionale del romanzo. Siamo davanti a un libro nel libro? Leggiamo fin dall’inizio le profezie di Melquiades, senza saperlo? Questo quello che Marquez vuole che pensiamo, ma che allo stesso tempo si affretta a smentire.
Cosa c’è di più arrogante di un autore che finge di aver fatto leggere al suo lettore le profezie misteriose di cui parla fin dall’inizio del libro? Una sola cosa: un autore che rivendica per sé la paternità della sua storia. Marquez ci dice: “pensa se le famose profezie di cui vuoi disperatamente sapere il contenuto, fossero sempre state difronte ai tuoi occhi e non hai fatto che desiderare quello che già possedevi”. Ce lo fa credere per un attimo. Ci fa sentire la vertigine della narrazione innestata dentro la narrazione che denuncia e si fa beffe della sua natura finzionale.
Per poi mostrarci che c’è, dopo questa, una vertigine ancora più alta: quella banale ed empirica dell’autore che scrive una storia. Un autore in carne ed ossa, Gabriel Garcia Marquez, che non pensa nemmeno un istante di lasciare che si possa confondere il suo libro con le pergamene di Melquiades, perché il suo libro contiene le pergamene ma non il contrario. La letteratura scioglie tutto, anche sé stessa nell’acido onnipotente del linguaggio, e pure se il messaggio del romanzo di Marquez è che le famiglie destinate a cent’anni di solitudine non hanno una seconda opportunità sulla Terra, Marquez stesso propone una soluzione aggirabile al destino segnato, dando alla famiglia Buendia l’immortalità di infinite occasioni, immortalate sulla pagina scritta del suo romanzo. Così, con la forza arbitraria della creazione poetica, Marquez decide di strappare per sempre la famiglia Buendia all’oblio dell’unica occasione, mentre afferma il contrario. L’effetto ironico non fa che enfatizzare la potenza arbitraria dello scrittore. Dico qualcosa ma in realtà nemmeno quello che dico vale per sempre perché il mio punto è che posso dirlo, non cosa dico. Il senso dell’opera è che essa esiste, e Marquez riesce a creare un testo in cui il fatto che esso esista diventi una meccanica dell’opera, una ragione della sua poetica, che concorre a creare la rete di significati che la fanno funzionare. Il senso dell’opera è anche il gioco metanarrativo del suo farsi, della letteratura come “gioco per ingannare le folle”, come un personaggio dice a un certo punto nel libro stesso.
Tutto conflagra in un unico punto dello spazio e del tempo, come un aleph di significati, memorie, destini e amori, solitudini che saranno sempre le stesse, ambizioni e delusioni che torneranno sempre uguali. Tutti hanno la stessa dignità perché tutto si eguaglia nella terribile insignificanza di tutto, le cui redini sono tenute dal dio-scrittore. Un bambino che si contraddice e si trastulla con la sua storia.
Mi sono chiesto più volte se Cent’anni di solitudine fosse un libro ottimista, se l’infantilismo dell’ambizione fosse più forte della maturità altera della prosa. Sicuramente la maturità della prosa lo rende un libro profondamente anti-ottimista. Ma questo non significa che sia un libro pessimista, nel senso che non si consuma nella frustrazione della scrittura e dello stile, pur mettendo in scena una frustrazione tenace e immortale nei suoi protagonisti e nella materia di cui tratta.
Non è ottimista perché non offre facili consolazioni, né riscatti di sorta, per sua stessa vocazione stilistica si fonda sulla a-moralità della circolarità del tempo. In questo senso si sforza di essere neutrale attraverso un lirismo disincantato e ironico, veggente e profetico, allusivo ma allo stesso tempo mai ansioso o smanioso. Il sogno della neutralità dello stile si raggiunge in molti modi, a volte è più facile raggiungerlo facendo a meno del modo attraverso cui sembra più facile raggiungerlo, cioè il realismo.
Con la sua perenne oscillazione bilaterale tra magia e realismo di cui ho parlato prima, nel rifiuto di dare risposte definitive sulla effettività dei fatti narrati, Marquez indica continuamente il farsi verbale della sua storia, una storia che esisterà sempre nell’oscillazione irrisolta tra realtà e possibilità onirica. Questa oscillazione rende il libro né ottimista né pessimista, collocandone la storia in un territorio dove non ha nemmeno senso porsi la domanda. Il sogno della neutralità dello stile è tale proprio perché cerca di raggiungere quel posto dove potersi guardare senza dover giudicare, quel posto dove svanisce il senso della ricerca di un senso dell’utile alle parole scritte e la scrittura coincide con quello che siamo e ci offre, come in uno specchio, la possibilità di guardare chi siamo. Chi non possiamo fare a meno di essere. Davanti all’ineluttabilità la morale perde di valore.
Questo è il senso del destino, un senso che è giustificatorio senza essere consolatorio e che per questo può suonare come un tormento infernale. Marquez riesce a rendere quel tormento con la stessa leggerezza di un gioco tra bambini. Ma di un gioco per bambini conserva anche l’assoluta serietà. Finché giochi alle sue regole, il gioco è tutto ciò che c’è. Il vento biblico, la pioggia quinquennale, il treno pieno di tremila morti in duecento vagoni gettati nel mare, il ghiaccio a Macondo, le 32 guerre di Aureliano Buendia… esistono solo nella loro impossibile verificabilità letteraria. Nella loro inemendabilità si trova la loro estrema realtà.
Non potremo dire, nemmeno all’interno dell’ontologia del testo se essi sono avvenuti o meno, non troveremo mai nessun indizio che confermi o smentisca la loro realtà, ma potremo asserire con assoluta certezza, al di là di ogni dubbio, l’irrefutabile, incontrovertibile fatto, che è inutile cercare più a fondo di così per capire se fossero o meno veri. La consolazione del romanzo, di ogni romanzo e di Cent’anni di solitudine, è che a un certo punto, finalmente, potremo fermarci e posare la penna.
Sollevare gli occhi dalla pagina senza sentire il bisogno di dimostrare alcunché.